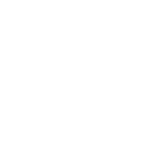GIORDANO BRUNO NOLANO SALUTA HEINRICH HEINZEL
nobilissimo
e illustre Signore di Elcovia
L’esempio della tua indole nobilissima,
l’altezza sublime del tuo vivacissimo ingegno e la generosa manifestazione
della tua perfetta umanità, illustre signore Heinzel, mi hanno stimolato,
spinto e condotto, in perenne testimonianza del rispetto che a te mi unisce, a
generare per te la sola già da tempo concepita e custodita tra le opere più
illustri che germineranno dal mio ingegno. Il suo argomento principale è la
composizione di immagini, segni e idee, per sviluppare in generale le capacità
di ritrovare argomenti, di organizzarli e memorizzarli. Se poi mi riuscirà di
conquistare, comprende e tener saldo quanto propongo, ricerco e tratto, in modo
che l’opera sia tanto facile da non poter essere più facile, tanto rapida da
non poter essere ulteriormente compendiata, tanto completa che solo a stento
un’altra potrà essere – o almeno essere ritenuta – più completa e più degna in
questo genere, mi sembrerà certo di aver conseguito un risultato non da poco.
Idea, immaginazione, assimilazione,
configurazione, designazione, notazione costituiscono nella sua totalità
l’opera di Dio, della natura e della ragione, e secondo l’analogia che
congiunge questi gradi, avviene che la natura mirabilmente riproduca l’azione
divina e subito dopo – quasi aspirando a mete ancor più alte – l’ingegno umano
emuli l’operazione della natura. Chi non vede con quanto pochi elementi la
natura produca realtà a tal punto molteplici? E questo, come nessuno ignora,
perché essa dispone quattro medesimi elementi semplici nel proprio sito, li
ordina, li compone, li applica, e formati e figurati sotto vari segni, li
conduce dal profondo della potenza alla sublime altezza dell’atto. Per Dio
immortale, può forse esistere per l’uomo qualcosa che sia più semplice dei
numeri? Primo, che cosa sia l’uno, il due, il tre, il quattro; secondo, che uno
non sia due, due non siano tre, tre non siano quattro; terzo, che uno e due
siano tre, che uno e tre siano quattro: fare questo è fare tutto, dire questo è
dire tutto, immaginare, esprimere con segni e ricordare questo consente che
ogni oggetto sia appreso, che sia inteso quanto si è appreso e ricordato quanto
si è inteso. La totalità di questa luce è presente, chiara e manifesta alla
nostra intelligenza più di quanto possa essere manifesta agli occhi esterni la
luce del sole; questa infatti sorge e tramonta, né è sempre presente ogni volta
che ad essa volgiamo lo sguardo, mentre quella non è meno presente a noi di quanto
noi lo siamo a noi stessi, ed è a tal punto presente a noi di quanto noi lo
siamo a noi stessi, ed è a tal punto presente alla nostra mente sa essere essa
stessa mente.
Ma vuoi sapere intento perché in così
pochi sanno e apprendono? Perché si crede – è questo che intendo – che un
principio così intimo a noi sia remoto al di là del cielo? Perché l’occhio vede
le altre cose così come vede se stesso? Quello che vede in sé tutte le cose, e
che è lui medesimo tutte le cose. Saranno certo simili a quello secondo una
ragione sublime se potessimo scorgere la sostanza della nostra specie; di modo
che il nostro occhio distinguesse se stesso, la nostra mente abbracciasse se
stessa. Allora, come sarebbe possibile intendere tutto, così non sarebbe
difficile fare tutto. Ma lo vieta la natura degli enti corporei e composti; la
sostanza di questa – che pure on è in sé soggetta a moto e quantità – consiste
infatti nel moto e nella quantità. Come dunque nello specchio possiamo vedere
non noi stesse nel fondamento profondo e indivisibile di cui consistiamo, ma
certi accidenti che promanano dalla superficie esterna – quali sono ad esempio
il colore e la figura – insieme ad una similitudine dell’occhio stesso, così il
nostro intelletto non vede se stesso in se stesso e tutte le cose in se stesse,
ma solo in una sorta di configurazione esteriore, simulacro, immagine, figura,
segno.
Tale è il significato del detto che,
riferito da Aristotele, era già stato in precedenza formulato dagli antichi
filosofi, e che pochi dei più recenti sono stati capaci di intendere: «Il
nostro intendere – ovvero, le operazioni del nostro intelletto – o è fantasia o
non è senza fantasia», e ancora: «Non intendiamo se non guardiamo i fantasmi».
Ed è per questo che noi comprendiamo non in una sorta di semplicità, stabilità
e unità, ma nella composizione, nel confronto e nella pluralità, mediante
discorso e riflessione. E se tale è il nostro ingegno, tali necessariamente
devono essere le sue opere, di modo che quando esso ricerca, trova, giudica,
dispone e ricorda non possa mai vagare oltre i limiti dello specchio, né
muoversi se non con immagini. Se dunque attraverso la natura è esposto uno
specchio terso e senza imperfezioni, e se attraverso l’arte rifulge vigorosa la
luce dei princìpi nell’orizzonte del raziocinio, allora secondo la facoltà
elargitaci dalle immagini chiare e perspicue che vengono a presentarsi al
nostro sguardo saremo indirizzati a quella somma felicità che si esplica in
atti di genere molteplice e che è massimamente propria dell’uomo in quanto
uomo.
Per illustrare il modo perfettamente
compiuto questa dottrina ho dunque compilato tre libri. Nel primo si affrontano
i princìpi generali che riguardano i diversi generi del significare; si
spiegano inoltre le condizioni carie secondo cui sono allestiti e disposti i
sostrati, impresse e dipinte le immagini; insegniamo poi ad edificare atri e
campi di generi diversi, e ne presentiamo anche di già edificati; tra questi
rientrano infine tutte le cose che possono essere dette, conosciute e
immaginate; lì sono contenute tutte le arti, le lingue, le opere, i segni.
Nel secondo libro sono le immagini dei
dodici prìncipi che sotto l’unico ottimo massimo ineffabile infigurabile sono
produttori, significatori ed elargitori secondi e medi di tutte le cose; e
tutte le realtà assistenti, circostanti, adiacenti, inerenti e insite a ciascun
principe sono state da noi esplorate per consentirne un impiego
straordinariamente fecondo: grammatico per i grammatici, e così per poeti,
oratori, studiosi della natura, astrologi, teologi, meccanici e teorici;
perché, infine, tutti possano impiegarlo in tutti i possibili modi. Una cosa
vorrei fosse chiara a tutti: in queste pagine non tratto, accumulando sinonimi,
della sciocca abbondanza retorica (sempre congiunta a scarsità di senso) dei
costruttori di discorsi artificiosi; i diversi vocaboli che considerati
dall’occhio del grammatico sono i sinonimi, per noi significano infatti cose
sempre diverse, o almeno in una prospettiva sempre diversa, allo stesso modo in
cui «signore», «possessore», «proprietario» non hanno il medesimo significato
rispetto all’ignoranza, al servo e al cavallo; questo perché nella curia della
filosofia non esistono termini perfettamente sinonimi, a meno di non annoverare
tra i filosofi quei grammatici del nostro tempo che disprezzando la proprietà
dei vocaboli, affettando come scimmie e pappagalli uno stile elegante e curato,
si fanno gran vanto di emulare Cicerone nel costituire il lessico delle
scienze, e mescolando parolette greche alle latine si comprano alle fiere,
insieme ad altre cose, anche la perizia delle lingue; ma tutti costoro, ben
riconoscibili dalle unghie, li poniamo nel novero degli animali bruti – in
quanto manca loro una buona parte del raziocinio umano – piuttosto che in
quello di grammatico arrogante e saputo.
Nel terzo libro presento invece le
immagini di trenta sigilli, le cui raffigurazioni e spiegazioni ho già
pubblicato in altra sede. Gli uomini istruiti e dotati di naturale acutezza
d’ingegno potranno scoprire molte di queste cose solo con una attenta lettura:
non mi rivolgo qui a Edipo o Tiresia. E tuttavia nessuno forse sarà capace di
intendere tutte le implicazioni e sotto tutti gli aspetti se non avrà creduto,
e forse neanche così. Ma per nessuno la lettura sarà senza frutto, a meno che
non sia cieco.
Ti saluto, e ama chi ti onora.